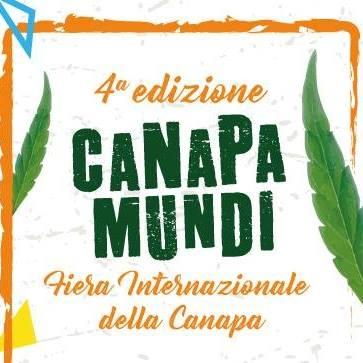Sergio Staino in mostra a Roma, al Teatro Villa Pamphilj dal 24 marzo al 20 aprile con una serie di tavole tutte dedicate al teatro. Saranno infatti allestiti, nello spazio espositivo al piano terra del Villino Corsini, i bozzetti dei costumi disegnati dal celebre vignettista satirico, papà di Bobo, commissionati dal festival Opera Barga per "Il potestà di Colognole", opera buffa di Jacopo Melani, con libretto di Giovanni Andrea Moniglia, una sorta di commedia degli equivoci con toni satirici accentuati, che fu composta e messa in scena per la prima volta nel 1657 per l'inaugurazione del Teatro della Pergola di Firenze. Ma non solo: l’esposizione sarà impreziosita anche da altri disegni in tema, come i bozzetti per i personaggi della commedia "Il mestiere di ridere" di Vinicio Gioli (di cui ha curato anche la regia) e da alcune esilaranti tavole satiriche dedicate a grandi personaggi quali Otello e Amleto. Da sempre Sergio Staino, artista poliedrico che nel corso della sua carriera si è avvicinato e ha interagito con diversi linguaggi artistici, è vicino al teatro e in tal senso numerosi sono i suoi impegni, da direttore artistico del Teatro Puccini di Firenze alla presidenza dell’Istituzione Servizi Culturali di Scandicci, fino alla direzione artistica dell’Estate Fiorentina. Sergio Staino sarà presente, sabato 1° aprile alle ore 11.30 per un incontro-conferenza con il disegnatore Fabio Magnasciutti e moderato da Anna Maria Piccoli.
Staino in mostra al Villino Corsini